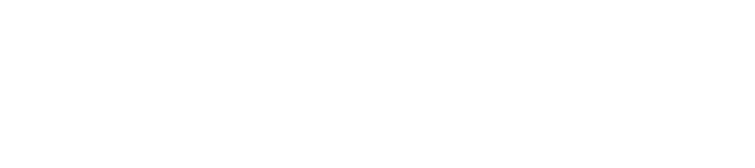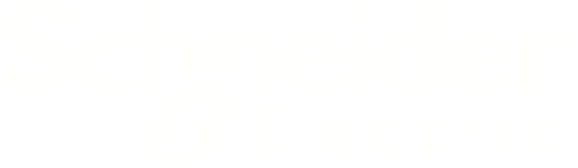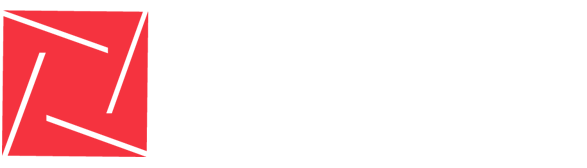Tra le distese di campi, i filari di pioppi e le anse dei fiumi della Pianura lombarda si nascondono piccoli gioielli di pietra, spesso lontani dai circuiti turistici più battuti: sono le pievi romaniche, antiche chiese rurali, abbazie e santuari che da secoli raccontano la storia, la fede e l’arte di queste terre. Opere sobrie, essenziali, costruite tra XI e XIII secolo, quando il romanico padano dava forma a luoghi di culto che ancora oggi sorprendono per armonia e forza espressiva.
Dalle colline dell’Oltrepò pavese ai borghi del Cremasco, dalle campagne mantovane alle valli bergamasche, passando per Brescia e Lodi, queste architetture custodiscono affreschi medievali, cripte millenarie, capitelli scolpiti e atmosfere di raccoglimento, immerse nella quiete del paesaggio. Questo articolo offre una guida per chi desidera scoprire le principali pievi romaniche nelle sei province lombarde, con suggerimenti pratici per visitarle e itinerari per costruire un viaggio alla ricerca di una bellezza autentica, fatta di pietra, storia e silenzio.

Provincia di Lodi

Duomo di Lodi (Cattedrale di Santa Maria Assunta). Iniziata nel 1160 e completata nelTrecento, la cattedrale di Lodi è una delle architetture romaniche più imponenti di tutta la Lombardia. La facciata in cotto, con protiro sorretto da leoni stilofori, introduce a un interno a tre navate ricco di opere d’arte di varie epoche. Nella navata destra spiccano pregevoli polittici rinascimentali dei fratelli Piazza, mentre nella sinistra si trova il monumento seicentesco al vescovo Vidoni. La navata centrale custodisce affreschi medievali, una rara scultura romanica dell’Ultima Cena e l’urna con le reliquie di San Bassiano, patrono di Lodi, collocata nella cripta accessibile ai visitatori. Il Duomo è normalmente aperto al culto e visitabile liberamente nelle ore diurne (contattare l’Infopoint in Piazza Broletto per conferma orari). Da notare che dal Duomo si accede anche al Museo Diocesano d’Arte Sacra, ricco di testimonianze storiche lodigiane.

Basilica dei XII Apostoli (San Bassiano) – Lodi Vecchio. Immersa nella campagna appena fuori dall’abitato di Lodi Vecchio, questa basilica affonda le sue origini nel IV secolo: fu consacrata nel 378 da San Bassiano, primo vescovo di Lodi, alla presenza di Sant’Ambrogio. Rimasta illesa nelle distruzioni medievali di Laus Pompeia (l’antica Lodi) nel 1111 e 1158, la basilica fu poi ricostruita in forme gotico-romaniche nel XIV secolo. Oggi si presenta con una facciata in cotto semplice, decorata da un rosone e monofore, e un interno a tre navate con volte a crociera. Notevoli sono gli affreschi trecenteschi che ornano volte e pareti, attribuiti al Maestro di San Bassiano (1320 ca.), finanziati dalle corporazioni locali: tra le scene dipinte spiccano quattro carri agricoli trainati da buoi, su sfondo blu stellato, un raro soggetto di vita rurale medievale. Nell’abside si trova un altorilievo del 1323 e nel presbiterio è custodito un frammento dell’antica vasca battesimale. La basilica, simbolo del Lodigiano, è visitabile liberamente; spesso sono organizzate visite guidate nei fine settimana. Sul retro, nell’area verde, sono visibili resti archeologici della Laus romana.

Abbazia di Santa Maria di Cerreto (Abbadia Cerreto). Fondata dai benedettini nel 1084 e poi affidata ai cistercensi di San Bernardo, questa abbazia sorge isolata nella campagna lodigiana. La chiesa abbaziale, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, conserva l’originaria struttura romanico-gotica lombarda: facciata a capanna in cotto, interno a tre navate su pilastri in mattone e coperture a volte ogivali. Colpisce il contrasto cromatico tra il rosso dei mattoni antichi e il bianco delle integrazioni moderne, frutto dei restauri del Novecento. All’interno spiccano una pala cinquecentesca di Callisto Piazza (la “Pala Cesi”) e una curiosa “cappella delle donne” laterale, così chiamata perché anticamente riservata alle fedeli secondo la regola cistercense. Il luogo emana pace e spiritualità, immerso nel silenzio rurale.
Altre pievi nel Lodigiano: meritano una citazione la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Zelo Buon Persico, piccola pieve rurale romanica citata già nel XIII secolo, e l’oratorio di San Biagio in Codogno (con affreschi romanici frammentari). Queste sono però meno fruibili al pubblico: spesso aperte solo in occasione di eventi o su richiesta presso le parrocchie locali.
Provincia di Mantova

Rotonda di San Lorenzo (Mantova). Nel cuore di Mantova, in Piazza delle Erbe, si trova questa suggestiva chiesetta a pianta circolare, il più antico luogo di culto mantovano (tradizione la vuole fondata nel 1082 per volere di Matilde di Canossa). La Rotonda, costruita in laterizio e seminterrata rispetto al livello attuale della piazza, richiama intenzionalmente l’Anastasis di Gerusalemme, il rotondo Santo Sepolcro: presenta infatti un vano centrale cilindrico circondato da un deambulatorio e da un matroneo sopraelevato, schema raro nell’architettura romanica padana. All’interno si possono ammirare resti di affreschi dell’XI-XII secolo e percepire un’atmosfera mistica, quasi fuori dal tempo. Dopo secoli di abbandono (fu sconsacrata e inglobata tra edifici, tanto da scomparire alla vista per lungo tempo), la Rotonda è stata restaurata nel Novecento e riaperta al culto.

Pieve di Santa Maria (Santuario della Madonna della Pieve) – Cavriana. Isolata su un colle panoramico alle porte del borgo di Cavriana, nell’Alto Mantovano, sorge questa pieve romanica interamente in cotto, tra le più importanti e meglio conservate del territorio. Già menzionata in un documento imperiale del 1037 (e con una tegola datata 1110 murata in facciata), fu edificata nell’XI-XII secolo e servì come chiesa parrocchiale fino al XVI secolo. La struttura presenta un’unica navata triabsidata (tre absidi semicircolari) e un campanile incorporato singolarmente disposto davanti all’absidiola sud, retto da un pilastro cilindrico – soluzione architettonica curiosa e tipica di alcune pievi mantovane. I muri esterni affascinano per l’uso di opus spicatum (mattoni disposti a spina di pesce) alternati a ciottoli e pietre, creando un mosaico policromo che richiama esempi coevi a Lomello. All’interno, coperto da capriate lignee, è custodito un altorilievo trecentesco raffigurante la Madonna col Bambino (Santa Maria Nova) collocato nel presbiterio. Dopo i danni subiti nella Seconda Guerra Mondiale, la pieve è stata restaurata negli anni ’50.

Pieve dei Santi Cosma e Damiano – Barbassolo. Nel borgo rurale di Barbassolo (frazione di Roncoferraro), sulle rive del fiume Mincio a sud-est di Mantova, si trova questa antica chiesa romanica spesso chiamata “Pieve dei Due Pozzi” o Santuario della Salute. La costruzione risale probabilmente al XII secolo (era tra i beni donati da Matilde di Canossa al monastero di Polirone agli inizi del XII sec. anche se la prima citazione documentaria è del 1546. L’attribuzione del titolo di “pieve” non è certa, poiché potrebbe essere stata cappella dipendente dalla perduta Pieve di San Pietro in Barbasso, poco distante. La chiesa, in mattoni, ha facciata semplice a capanna e interno a navata unica con cappelle laterali aggiunte in epoca successiva (in parte rimosse nei restauri moderni per ripristinare l’aspetto originario. Dopo un periodo di degrado nel Settecento, importanti restauri negli ultimi anni ne hanno esaltato la sobrietà romanica. Oggi la pieve di Barbassolo appare spoglia e raccolta, ideale per un momento di contemplazione: all’altare maggiore custodisce una pala del ‘700 raffigurante la Madonna del Carmine con Santi (segno della presenza carmelitana nel passato).
Abbazia di San Benedetto in Polirone – San Benedetto Po. Pur non essendo una “pieve” ma un vasto complesso monastico, l’abbazia di Polirone merita una menzione per importanza storica e turistica. Fondata nel 1007 da Tedaldo di Canossa (nonno di Matilde), divenne uno dei principali centri benedettini dell’Italia settentrionale. Matilde di Canossa vi fu sepolta nel 1115, conferendo ulteriore prestigio al luogo. Oggi il monastero, affacciato sul fiume Po, offre ai visitatori chiostri silenziosi, la grande basilica abbaziale (rinnovata in forme rinascimentali da Giulio Romano, ma con cripta romanica originale), il museo civico polironiano e una suggestiva foresteria.

Provincia di Cremona

Duomo di Cremona e Battistero. Nel centro di Cremona, affacciato su Piazza del Comune, si erge lo straordinario complesso della Cattedrale di Santa Maria Assunta con il Torrazzo e il Battistero, simboli della città. Il Duomo, iniziato nel 1107 e consacrato nel 1190, è un capolavoro del romanico padano, poi arricchito nel Gotico e Rinascimento. La facciata in marmo bianco e rosa presenta un elegante protiro con leoni stilofori, loggette e rosone centrale; al fianco svetta il Torrazzo, altissima torre campanaria (112 metri) terminata nel 1309, dalla cui cima la vista spazia sulla città. L’interno basilicale a tre navate sorprende per il ciclo di affreschi cinquecenteschi che ne ricoprono le pareti (Storie dell’Antico e Nuovo Testamento, opere di Boccaccio Boccaccino, Pordenone, Romanino, etc.), testimonianza della vivacità artistica locale. Nella navata destra è custodito il celebre Crocefisso ligneo del XII secolo, che secondo tradizione accompagnò Cremona nella battaglia di Lepanto. Visite: il Duomo è aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 12 e dalle 15 alle 19 (ingresso libero, rispettando le funzioni). Adiacente al Duomo sorge il Battistero di San Giovanni (1167), edificio romanico a pianta ottagonale in mattoni e marmo, con cupola piramidale: all’interno, sobrio ed essenziale, è visibile una grande vasca battesimale per immersione.

Pieve di San Martino – Palazzo Pignano. In un piccolo paese tra Crema e Lodi, sorge una delle pievi più antiche della Lombardia. La chiesa di San Martino fu infatti costruita alla fine dell’XI secolo su un sito cristiano ancora più antico: scavi archeologici hanno rivelato le fondamenta di una chiesa paleocristiana del V secolo sotto la navata sud . Esternamente la pieve romanica si presenta in mattoni con tracce di opus spicatum e murature molto rimaneggiate (segno delle tante ricostruzioni subite nei secoli). La facciata a capanna è semplice, mentre l’interno è a tre navate divise da robusti pilastri alternati in pietra e laterizio. Colpisce l’altezza della navata centrale in rapporto all’ampiezza, caratterizzata da sei campate regolari. Particolarità: sul lato sud, protetti da vetrate, sono visibili i resti del battistero a pianta circolare della chiesa del V secolo – un reperto eccezionale, con parte della vasca battesimale paleocristiana. La pieve di Palazzo Pignano ebbe un ruolo importante nel Medioevo: era sotto la diocesi di Piacenza (ancora prima che Crema avesse una propria diocesi) ed è considerata la “chiesa madre” originaria della diocesi cremasca

Chiesa di San Bassano – Pizzighettone. Questa chiesa, dedicata al medesimo santo venerato a Lodi, è la parrocchiale della cittadina fortificata di Pizzighettone, sulle rive dell’Adda. L’edificio originario fu costruito nel XII secolo, ma ha subito modifiche e aggiunte nei secoli successivi (in particolare nel Settecento furono aggiunte cappelle poi eliminate nell’800 per ripristinare l’aspetto romanico. Oggi la facciata a capanna in mattoni, semplice ed intonacata, cela un interno a tre navate. Durante restauri ottocenteschi sono venuti alla luce affreschi medievali, oggi visibili in controfacciata e in alcune campate, tra cui figure di santi e decorazioni geometriche.
Altri siti nel Cremonese: la Chiesa di San Sigismondo a Cremona (splendido esempio di rinascimento lombardo, costruita però nel luogo di un monastero medievale), e la Pieve di San Genesio a Castelverde (di origine altomedievale, ricostruita) sono ulteriori tappe per gli appassionati, sebbene meno originali nell’aspetto romanico. Anche Crema, pur più nota per il Duomo gotico, conserva resti romanici nella chiesa di San Benedetto (cripta).
Provincia di Pavia

Basilica di San Michele Maggiore (Pavia). Vero capolavoro del romanico lombardo, San Michele fu chiesa palatina del regno italico: qui si svolgevano le incoronazioni dei re, tra cui quella celebre di Federico Barbarossa nel 1155. L’attuale basilica fu costruita tra XI e XII secolo sul sito di una precedente chiesa longobarda del VII secolo. La facciata in arenaria dal caratteristico colore dorato ha un profilo a capanna “a vento” (più alta del tetto) ed è ricca di sculture: figure zoomorfe e motivi floreali si intrecciano nei capitelli e nei bassorilievi, testimonianza dell’immaginario medievale. L’interno, a croce latina e tre navate sorrette da poderose colonne, crea un’impressione di slancio verticale grazie ai matronei e al tiburio ottagonale che illumina il centro della chiesa. Nella cripta, ampia e suggestiva, riposano le reliquie di San Siro, primo vescovo di Pavia.
Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro (Pavia). Così chiamata per l’originaria volta dorata della chiesa paleocristiana preesistente, San Pietro in Ciel d’Oro fu rifondata dal re longobardo Liutprando nell’VIII secolo e ricostruita in forme romaniche entro il 1132 (anno della nuova consacrazione). La facciata a capanna in cotto, suddivisa da contrafforti, presenta decorazioni in stile romanico-lombardo sobrie ed eleganti. L’interno, a tre navate su pilastri, custodisce tesori di inestimabile valore per la cristianità: al centro del presbiterio si trova l’Arca di Sant’Agostino, monumentale arca marmorea gotica scolpita nel Trecento, che contiene le reliquie di Sant’Agostino d’Ippona arrivate a Pavia nel 724. La basilica ospita anche le spoglie di Severino Boezio, filosofo romano del VI secolo, sepolto qui e celebrato da Dante nel Paradiso. Visivamente colpiscono i resti di affreschi medievali absidali e la bella struttura della cripta, sorretta da colonne con capitelli scolpiti.


Chiesa di San Teodoro (Pavia). Nascosta tra le viuzze del centro storico, questa chiesa romanica del XII secolo dedicata a San Teodoro, protettore dei pescatori, è un piccolo gioiello. La facciata in cotto a capanna è abbellita da loggette cieche e bacini ceramici; l’interno, a tre navate su colonne, conserva affreschi quattrocenteschi di scuola lombarda. Il pezzo forte per i visitatori è il grande affresco absidale raffigurante Pavia come appariva nel 1525, con una vista panoramica dettagliata della città e del fiume Ticino, popolata da figure di santi (è visibile anche il grande pesce del Ticino, legato a una leggenda locale). Questa “veduta di Pavia” affrescata è di enorme interesse storico oltre che artistico.

Pieve di San Zaccaria (Rocca Susella, Oltrepò Pavese). Nelle colline dell’Oltrepò, a pochi km da Godiasco, sorge isolata questa piccola pieve del XII secolo, unica superstite romanica della zona. Costruita dai magistri comacini in pietra arenaria e laterizi, ha una semplice facciata a capanna bicroma (fasce alternate di mattoni e pietra locale) che la rende assai particolare nel panorama lombardo. L’interno è a tre navate spartite da pilastri; di originale restano pochi ma pregevoli elementi: due capitelli scolpiti ai lati del presbiterio raffigurano simbolicamente il destino dell’anima buona e una lotta tra uomini e animali. Piccoli bassorilievi in arenaria sulle pareti completano la decorazione sobria, affine a quella di chiese pavesi maggiori. Questa pieve fu per secoli centro spirituale della Valle Ardivestra, capo-pieve di diverse parrocchie circostanti. Caduta in disuso nell’Ottocento e adibita persino a uso agricolo, è stata salvata da provvidenziali restauri nel Novecento che ne hanno ripristinato l’aspetto originario.
Eremo di Sant’Alberto di Butrio (Ponte Nizza, Oltrepò). Tra boschi di querce e castagni nell’alta Valle Staffora si nasconde l’eremo di Butrio, luogo di spiritualità fondato attorno al 1030 da Sant’Alberto. Il complesso comprende alcune piccole chiese romaniche: la chiesetta di Sant’Antonio, con affreschi popolari del tardo Quattrocento, e la chiesa di Sant’Alberto (XII sec.) dove riposano le reliquie del santo e si possono ammirare affreschi votivi raffiguranti il marchese Malaspina, antico benefattore. Dell’antico monastero resta un suggestivo chiostrino con pozzo, e una robusta torre di guardia medievale. L’eremo nasce infatti da un fatto miracoloso: il marchese Alberto Malaspina, riconoscente ad Alberto per la guarigione del figlio muto, fece costruire una chiesa romanica per l’eremita e i suoi discepoli. Oggi Sant’Alberto di Butrio è un’oasi di pace dove arte, natura e fede si fondono: dal terrazzo panoramico lo sguardo spazia sulle valli sottostanti in un silenzio irreale.


Basilica di Santa Maria Maggiore e Battistero di San Giovanni ad Fontes – Lomello. Nella Lomellina pavese, a Lomello, si trova un complesso di eccezionale interesse: la basilica di Santa Maria Maggiore (costruita tra il 1025 e il 1040, tra i primissimi esempi di romanico in Italia e il vicino battistero ottagonale, risalente al V-VI secolo. La basilica romanica, voluta probabilmente dai re longobardi, ha tre navate e conserva le volte a crociera più antiche d’Italia, testimonianza delle sperimentazioni strutturali dell’epoca. La muratura alterna ciottoli di fiume e mattoni, con decorazioni ad archetti pensili; all’interno sono visibili resti di affreschi medievali e un bell’ambone scolpito. Accanto, il Battistero di San Giovanni (fine V secolo) colpisce per la sua forma: un vano ottagonale con abside e vasca battesimale centrale, in cui anticamente i catecumeni venivano battezzati per immersione. Qui secondo la tradizione la regina Teodolinda sposò il duca Agilulfo nel 590. Visite: il complesso è aperto in occasione di eventi culturali o su prenotazione tramite il Comune/Pro Loco; è spesso meta di visite guidate per il suo rilievo storico. Vale la pena di inserirlo in un itinerario in Lomellina, magari abbinandolo al vicino castello di Sartirana o alla città di Vigevano.
Provincia di Bergamo

Basilica di Santa Maria Maggiore (Città Alta, Bergamo). Edificata a partire dal 1137 come chiesa votiva della città, Santa Maria Maggiore rappresenta il fulcro spirituale di Bergamo Alta. La struttura romanica originaria è ancora ben leggibile: esternamente sono visibili le forme robuste della basilica a croce greca irregolare, in pietra locale, con leoni stilofori che sorreggono gli protiro dei portali laterali (le eleganti porte di ingresso, tra cui il celebre Portale dei Leoni Bianchi). L’interno, a navata unica con profonde arcate ogivali, fu riccamente decorato tra ‘500 e ‘600: arazzi fiamminghi e barocchi rivestono le pareti, affreschi del Tiepolo ornano la volta, rendendo l’atmosfera sfarzosa (in netto contrasto con la sobrietà esterna). Da notare il presbiterio con coro ligneo intagliato da Lorenzo Lotto e l’iconico confessionale del Fantoni.

Rotonda di San Tomè (Almenno San Bartolomeo). Nella campagna a ovest di Bergamo, in località Almenno, sorge la suggestiva chiesa di San Tomè, uno degli esempi più particolari di architettura romanica in Italia. Si tratta di una chiesa a pianta circolare edificata tra fine XI e inizi XII secolo, costituita da tre cilindri concentrici sovrapposti: un corpo centrale rotondo, un deambulatorio anulare e un matroneo al livello superiore. Esternamente la Rotonda presenta una muratura in pietra locale con eleganti archetti e lesene; al culmine svetta un piccolo tiburio cilindrico. L’interno è di grande fascino: otto colonne monolitiche sorreggono le arcate del matroneo creando giochi prospettici e di luce unici (nei solstizi, in particolare, i raggi di sole penetrano creando effetti simbolici). Si ipotizza che San Tomè sorga sui resti di un tempietto o mausoleo romano, data l’originalità della pianta. Oggi il luogo emana spiritualità arcaica ed è utilizzato anche per concerti di musica antica per via dell’acustica particolare.

Chiesa di San Giorgio in Lemine (Almenno San Salvatore). A poca distanza da San Tomè, sull’altra sponda del fiume Brembo, si trova un’altra preziosa chiesa romanica: San Giorgio, parte dell’antica pieve di Lemine. Fondata nell’XI secolo, la chiesa ha pianta basilicale a tre navate e conserva la struttura romanica quasi intatta. L’esterno in pietra è semplice, con una facciata a capanna e un campaniletto a vela posteriore. Ma l’interno vi sorprenderà per il suo ciclo di affreschi: sulle pareti e sui pilastri sono visibili pitture che vanno dal XII al XV secolo, tra cui una splendida Ultima Cena duecentesca, figure di santi e scene bibliche stilisticamente primitive ma di grande efficacia. Questi affreschi offrono uno spaccato dell’arte devozionale locale nel Medioevo. Notevole è anche il pavimento in ciottoli di fiume posati a disegno (restaurato), e la tribuna presbiteriale rialzata sotto cui passava, secondo alcuni studiosi, un anello di deambulazione per i pellegrini.

Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella (Sotto il Monte). Sulle colline a ovest di Bergamo, nel paese natale di Papa Giovanni XXIII, sorge l’antica abbazia di Fontanella. Fondata nel 1080 dal monaco Alberto di Prezzate, appartenne ai Cluniacensi e poi agli Olivetani. La chiesa abbaziale romanica, dedicata a Sant’Egidio, è un edificio in pietra a tre navate molto ben conservato: all’esterno colpisce la facciata semplice con loggetta e il campanile tozzo, mentre all’interno regna un’austera armonia, con arcate a tutto sesto poggianti su pilastri alternati a colonne. La cripta sottostante (XI sec.) è un piccolo gioiello: un ambiente ipogeo a nove campate con volte a crociera sostenute da colonnine e capitelli scolpiti (alcuni decorati con figure animali e motivi vegetali). L’abbazia è circondata dal verde e trasmette serenità; nel piccolo chiostro si può sostare in raccoglimento.
Abbazia di Pontida. Merita infine menzione l’abbazia di San Giacomo a Pontida, fondata nel 1076 da Alberto da Prezzate come primo monastero cluniacense in Lombardia. Anche se oggi la chiesa abbaziale si presenta in forme barocche all’esterno, conserva all’interno parti romaniche (absidi e brani di affresco XII sec.) e soprattutto mantiene vivo un importante pezzo di storia: secondo la tradizione proprio qui venne stretto il Giuramento di Pontida (1167) tra i comuni lombardi contro il Barbarossa. L’abbazia è tuttora abitata da monaci benedettini e visitabile in parte (chiostro cinquecentesco, antica sala capitolare). È un luogo carico di spiritualità e storia, che può arricchire un percorso romanico bergamasco fuori dalle mete più note.

Provincia di Brescia
Duomo Vecchio (La Rotonda) – Brescia. Nel centro di Brescia, in Piazza Paolo VI, sorge accanto alla cattedrale nuova un’imponente costruzione cilindrica in pietra: è la concattedrale invernale di Santa Maria Assunta, detta Duomo Vecchio o Rotonda. Costruita a partire dall’XI secolo sulle basi di una precedente basilica, la Rotonda è uno dei rarissimi esempi in Italia di chiesa romanica a pianta circolare (se ne contano appena 23 in tutta la penisola). Esternamente colpisce la massa compatta in pietra bianca di medolo, con due ordini sovrapposti di muri cilindrici e piccole finestre; l’aspetto severo era in origine ancor più slanciato da un’alta torre campanaria poi crollata nel Settecento. All’interno, entrando dal portale barocco (aggiunto nel 1571) si scende di qualche gradino: la chiesa infatti si sviluppa in profondità con un ampio ambulacro anulare al piano inferiore, scandito da colonne e pilastri che sorreggono il tamburo superiore. Al centro, elevato, vi è il corpo cilindrico principale con l’altare: un tempo questo dislivello doveva accentuare la separazione tra il clero e i fedeli. Nella penombra dell’ambulacro si possono osservare resti di mosaici e lapidi dell’antica basilica; salendo poi verso l’altare si ammira la copertura a cupola (ricostruita nel XVI secolo). Il Duomo Vecchio conserva importanti opere d’arte: il sarcofago marmoreo di Berardo Maggi (vescovo e primo signore di Brescia, †1308), opere scultoree di Bonino da Campione e tele del Moretto e Romanino collocate lungo le pareti.


Chiesa di San Salvatore e Museo di Santa Giulia – Brescia. Inserita nel complesso monastico longobardo di Santa Giulia (sito UNESCO), la chiesa di San Salvatore (753 d.C.) e la chiesa di Santa Maria in Solario (XII sec.) offrono un viaggio nell’alto medioevo bresciano. San Salvatore è precedente al romanico, in stile longobardo, ma fu arricchita in epoca romanica di affreschi e capitelli; Santa Maria in Solario, invece, fu costruita nel 1190 come cappella e tesoro del monastero: ha pianta quadrata con tiburio ottagonale ed è celebre per la volta a ombrello decorata da un cielo stellato medievale. Nel museo sono conservati il Crocifisso di Desiderio (croce astile altomedievale) e la preziosa Vittoria Alata romana. Per un turista interessato all’arte romanica, il complesso di Santa Giulia è imperdibile, perché mostra la continuità tra l’arte longobarda e quella romanica in Lombardia.
Pieve di Santa Maria del Tenesi – Manerba del Garda. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, nel territorio della Valtenesi, si trova l’antica Pieve di Manerba, dedicata a Santa Maria. Edificata attorno all’XI-XII secolo, questa chiesa campestre era il centro religioso per i villaggi della zona (il toponimo Tenesi deriva da plebem de Tenesi citata già nel 1145). La pieve sorge in località Pieve Vecchia, ai piedi della Rocca di Manerba: esternamente si presenta in pietra e mattoni, con facciata semplice e campanile a vela. L’interno a tre navate mostra tracce degli ampliamenti successivi (XIII-XIV sec.) con affreschi che vanno dal XII al XV secolo. Tra essi, di particolare interesse, un frammento di affresco del XII secolo interpretato come Martirio di Sant’Orsola e varie immagini mariane. La pieve fu parrocchia fino al 1750, poi sostituita da una chiesa nuova nel borgo; questo l’ha preservata da eccessive manomissioni.

Chiesa di Sant’Andrea – Toscolano Maderno. Nel paese di Maderno, sulla riva ovest del Garda, sorge la splendida chiesa romanica di Sant’Andrea, costruita nel XII secolo. La facciata in pietra chiara è decorata da un ricco portale strombato e da archetti pensili; il campanile massiccio conserva monofore originali. L’interno basilicale, a tre navate su colonne, è stato rimaneggiato nel barocco, ma mantiene l’abside semicircolare romanica. All’interno spicca una piccola tavola trecentesca di scuola veneziana attribuita a Paolo Veneziano (raffigurante la Madonna col Bambino), testimonianza dei legami artistici con la Serenissima. Sant’Andrea di Maderno è considerata una delle chiese romaniche più importanti del Bresciano per l’armonia delle sue proporzioni e la purezza dello stile.

Chiesa di San Pietro in Mavino – Sirmione. Sulla punta della penisola di Sirmione, in posizione panoramica tra gli ulivi, sorge questa piccola chiesa dedicata a San Pietro, originariamente costruita nel VIII secolo e riedificata in forme romaniche nel XI-XII secolo. “In Mavino” significa “sulla collina”, infatti la chiesetta domina dall’alto il borgo di Sirmione. L’esterno è semplice, con muratura in pietra e un campanile a bifore aggiunto nel 1070; l’interno a tre piccole navate custodisce affreschi di varie epoche: interessanti quelli dell’VIII-IX secolo (in stile bizantino, tra i pochissimi così antichi in Lombardia) accanto a cicli del XIII e XIV secolo sulle pareti. I temi variano da figure di Apostoli, a una Madonna in trono, fino a motivi geometrici. Il pavimento è ancora in ciottoli e cotto. L’atmosfera è intima, quasi ascetica, lontana dal flusso turistico del centro di Sirmione.

Pieve di San Pancrazio – Montichiari. Su un’altura a pochi km da Montichiari, nella frazione Novagli, si trova la Pieve di San Pancrazio, chiesetta romanica isolata tra i campi. Risalente al XII secolo, fu la prima parrocchiale di Montichiari. L’edificio è in pietra e mattoni, con facciata a capanna molto semplice; all’interno ha un’unica navata con abside semicircolare. Ciò che la rende speciale sono gli affreschi duecenteschi e trecenteschi che decorano l’abside e le pareti: figure di Cristo Pantocratore, santi e motivi geometrici, sebbene frammentari, permettono di immaginare la ricchezza originaria. Interessante anche la cripta sotto il presbiterio, a cui si accede da botole, dove si scorgono tracce di affreschi più antichi. Oggi San Pancrazio è sconsacrata ma viene aperta occasionalmente per eventi culturali o messe all’aperto nel giorno del santo (12 maggio).
Altre mete romaniche nel Bresciano: segnaliamo la Pieve di San Siro a Capo di Ponte in Valcamonica (antica pieve dell’XI sec. con affreschi, contesto affascinante vicino ai siti delle incisioni rupestri UNESCO), e la Pieve di San Giovanni Battista a Erbusco in Franciacorta (resti di un’abside e campanile romanico tra i vigneti). Entrambe sono visite consigliate agli appassionati, da inserire in itinerari naturalistici (rispettivamente il Parco di Naquane a Capo di Ponte e la Strada del Vino in Franciacorta).
Itinerari consigliati
Per chi volesse scoprire più pievi romaniche in un tour tematico, ecco alcuni suggerimenti di itinerario:
- Itinerario nel Lodigiano e Cremasco: Partendo da Lodi (Duomo e Tempio dell’Incoronata come bonus rinascimentale), proseguite per Lodi Vecchio (Basilica di San Bassiano). Da qui, raggiungete Abbadia Cerreto per la quiete dell’abbazia cistercense. Nel pomeriggio, spostamento verso il Cremasco: tappa a Palazzo Pignano per la pieve e il sito archeologico paleocristiano. Pernottamento a Crema (che offre altre chiese e un bel centro storico). Il giorno seguente, visitate Cremona: Duomo, Battistero e Torrazzo la mattina; dopo pranzo, breve deviazione a Pizzighettone per le mura e la chiesa di San Bassano. Questo itinerario unisce luoghi vicini tra loro (Lodi e Crema distano circa 30 km) ed è fattibile in auto o bici (il territorio è pianeggiante e ricco di piste ciclabili lungo i canali).
- Itinerario matildico nell’Oltrepò Mantovano: Dedicato agli amanti della storia di Matilde di Canossa, questo percorso tocca le pievi romaniche legate al suo dominio. Iniziate da San Benedetto Po (Abbazia di Polirone) per immergervi nella storia canossiana. Proseguite verso nord-est lungo il Po fino a Barbassolo (Roncoferraro) per la Pieve dei Santi Cosma e Damiano. Da qui, puntate a Mantova città: visita serale alla Rotonda di San Lorenzo, magari approfittando dell’illuminazione suggestiva in piazza Erbe. Il giorno seguente, risalite verso le colline moreniche: fermatevi a Cavriana (Pieve di Santa Maria della Pieve) e concludete a Castiglione delle Stiviere (non romanica ma interessante per il museo aloisiano) o Desenzano sul Garda per un po’ di relax sul lago. Questo tour richiede l’auto; le distanze non sono eccessive e permettono di gustare anche la cucina locale (il salame mantovano nelle trattorie di campagna, i tortelli di zucca, ecc.).
- Itinerario nelle valli bergamasche: Partite da Bergamo Alta (Santa Maria Maggiore, con una passeggiata sulle mura venete patrimonio UNESCO). Scendete poi in Val Brembana verso Almenno San Bartolomeo/Salvatore: qui concentratevi sul Circuito del Romanico dell’Agro di Lemine, visitando la Rotonda di San Tomè e San Giorgio in Lemine (sono a 5 minuti di auto l’una dall’altra, possibile visita guidata combinata nei weekend). Nel pomeriggio, tappa a Sotto il Monte per l’abbazia di Fontanella, immersa nel verde. Pernottate magari in un agriturismo sui colli bergamaschi. Il giorno successivo potete spingervi in Valle Seriana fino a Clusone (per ammirare, oltre all’Orologio planetario, l’affresco della Danza Macabra, esempio di iconografia tardomedievale) oppure, se preferite rimanere sul tema romanico puro, visitare Albino (chiesetta di San Giuliano) e Alzano Lombardo (Museo d’arte sacra con sezioni medievali). Questo itinerario offre una full immersion tra pievi e natura, con la possibilità di degustare formaggi tipici (taleggio in Val Taleggio, raggiungibile da Almenno) e di godere del fresco delle prealpi orobiche.
- Itinerario sul Lago di Garda (Brescia e Mantova): un percorso che unisce fede, arte e panorami lacustri. Iniziate da Sirmione con San Pietro in Mavino al mattino (luce morbida e poca folla), poi trasferitevi a Toscolano Maderno per la chiesa di Sant’Andrea e magari un pranzo sul lungolago. Nel pomeriggio salite alla Pieve di Santa Maria di Manerba del Garda, quindi proseguite verso Solferino e San Martino della Battaglia (luoghi risorgimentali con torri panoramiche). Verso sera raggiungete Cavriana: la Pieve di Santa Maria sul colle al tramonto regala un’atmosfera magica, con vista sulle colline moreniche. Pernottate in agriturismo nei dintorni di Cavriana/Volta Mantovana assaporando i vini locali (Garda Colli Mantovani). Il giorno dopo, scendete a Mantova per approfondire la città (Rotonda di San Lorenzo di giorno, Basilica di Sant’Andrea per la reliquia del Sangue di Cristo, anche se non romanica) e concludete con un giro in battello sui laghi mantovani. Questo itinerario vi farà scoprire come il romanico lombardo sia diffuso in contesti paesaggistici molto diversi: dalle rive del lago alle colline, fino alla pianura fluviale.
Prima di partire per un tour delle pievi romaniche, ricordate di verificare gli orari di apertura aggiornati (soprattutto per i piccoli edifici fuori città che talvolta aprono solo su richiesta o in occasioni particolari). Molte di queste chiese si trovano in borghi minori: approfittatene per parlare con la gente del posto, spesso custode di aneddoti e leggende legate a questi luoghi antichi. Un viaggio tra le pievi romaniche lombarde è un viaggio nel tempo, alla scoperta di radici profonde fatte di spiritualità, arte e comunità locali – un’esperienza che arricchirà il vostro itinerario turistico con emozioni autentiche.